Filosofo: le domande socratiche erano un tentativo di difendersi dal populismo e dalla polarizzazione

Dott. Habil. Krzysztof Łapiński insegna storia della filosofia antica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Varsavia. È autore dell'ultima biografia di Socrate, "The Wisest. Biography of Socrates", pubblicata dalla casa editrice Agora.
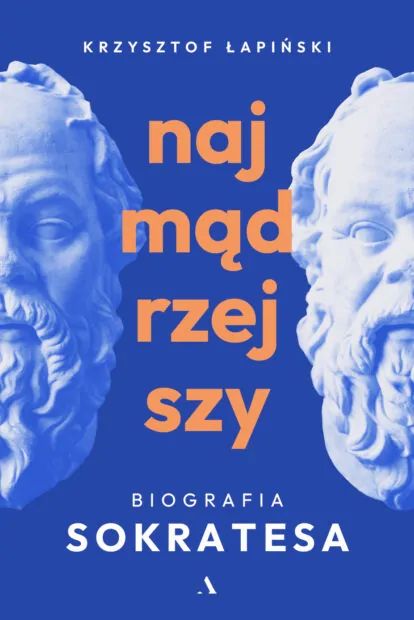
PAP: Gli studenti di Socrate e varie fonti storiche trasmettono un'immagine ambigua del filosofo ateniese, attribuendogli motivazioni d'azione o opinioni diverse. Socrate stesso non ha lasciato scritti. Come si crea quindi un'immagine coerente di un personaggio così multidimensionale?
Krzysztof Łapiński: Questo problema fu notato all'inizio del XIX secolo dal ricercatore tedesco Friedrich Schleiermacher. Affermava che l'immagine di Socrate nei dialoghi del suo allievo Platone contiene troppi elementi rispetto alla verità storica. Socrate è lì una figura monumentale, quasi sovrumana, e, per di più, spesso propaga concetti puramente platonici. D'altro canto, nel caso di un altro studente, Senofonte, sembra che manchi qualcosa nell'immagine di Socrate; abbiamo l'impressione che un tale Socrate non avrebbe compiuto nessuna grande rivoluzione nella filosofia, non avrebbe saputo seminare il fermento intellettuale che gli viene attribuito.
Viene raffigurato come un cittadino calmo e perbene, quindi non è chiaro il motivo per cui una persona come lui fosse così odiata da essere condannata a morte. E ora dobbiamo cercare di trovare alcuni punti in comune tra queste e molte altre voci, per metterle in ordine. Dobbiamo anche ricordare che questi autori erano scrittori molto ambiziosi e sofisticati. Costituivano una specie di gruppo di narcisisti letterari che gareggiavano ferocemente tra loro per ottenere il riconoscimento da parte dei lettori. Ognuno di loro ha cercato di dimostrare di aver compreso meglio di chiunque altro il pensiero di Socrate. Quindi scrivendo di lui, hanno scritto un po' di loro stessi.
Nella mia interpretazione del personaggio di Socrate mi sono trovato in aiuto di testi che a prima vista non sembravano essere delle fonti storiche evidenti, ovvero le commedie. Hanno il vantaggio di essere stati scritti quando Socrate aveva circa 40 o 50 anni. Al contrario, Platone e Senofonte scrissero di Socrate molti anni dopo la morte del loro maestro. Le fonti dei testi comici possono sembrare sospette. Ad esempio, nella commedia Le Nuvole di Aristofane, Socrate trascorre intere giornate appeso al soffitto in una cesta, perché si suppone che l'aria lassù sia più fine e quindi si riesca a pensare meglio. Naturalmente, questa non può essere considerata una verità storica.
A volte, però, gli autori di commedie, invece di prendere in giro il loro eroe, ne cantano le lodi. E nel caso di Socrate, tutte le commedie a noi note in cui appare sono unanimi nel testimoniare che egli apprezzava l'indipendenza, disprezzava l'adulazione, non si curava né della ricchezza né della carriera politica ed era capace di guidare le discussioni in modo efficace. Vediamo quindi Socrate dimostrare che ciò che è importante è la pratica della filosofia, la messa in pratica degli ideali, e non solo speculazioni puramente teoriche.
PAP: Hai detto che il contributo più importante di Socrate alla filosofia è stato quello di trasformarla da un campo teorico a uno pratico. Ciò sembra piuttosto poco ovvio nel caso di un filosofo, soprattutto se antico.
K.Ł.: Socrate credeva che la filosofia fosse prima di tutto un modo di vivere. Questo è il messaggio principale che egli porta ad Atene, desiderosa di dialogo e ricettiva a tutte le novità intellettuali. Secondo lui non basta proclamare certi concetti, bisogna anche viverli.
La seconda cosa importante che attribuiamo a Socrate è l'enfasi che egli attribuiva al porre domande e all'essere curioso. A mio parere, e ne parlo nel libro, potrebbe essere stata una reazione alla critica della filosofia mossa dal sofista Gorgia. Sosteneva che la filosofia non aveva alcun valore perché i suoi rappresentanti non erano in grado di concordare tra loro su nessuna questione. Socrate dimostra che a volte le domande sono più importanti delle risposte. E sono l'essenza della filosofia.
Leszek Kołakowski riteneva che Socrate dovesse essere un punto di riferimento per ogni filosofo. In filosofia le domande sono senza tempo, mentre le risposte sono transitorie, a volte migliori, a volte peggiori. Generazioni di filosofi si sono confrontate ripetutamente con le stesse domande universali.
Il messaggio di Socrate era che un filosofo è qualcuno che si trova in uno stato di costante attività intellettuale, che è in grado di mettere in discussione gli schemi consolidati, di minare ciò che sembra ovvio alla maggior parte delle persone ma che in realtà non lo è affatto. È qualcuno che viene e dice: vivi secondo degli stereotipi, ci credi, ma hai mai pensato al loro significato? Ci costringe a riconsiderare questioni che prima sembravano note e indiscutibili.
L'atteggiamento di Socrate è antidogmatico. Per lui la cosa più importante era la precisione del pensiero e l'essere guidati dalla ragione nella vita. Credeva che un pensiero ordinato si traducesse a sua volta in un'azione ordinata e corretta.
Oggigiorno Socrate si chiederebbe forse: certe norme sociali, questioni politiche o economiche dovrebbero essere considerate assolutamente vere? Forse vale la pena di analizzare con occhi nuovi ciò che sembra ovvio? Soprattutto quando tali convinzioni causano danni ad altre persone. Innanzitutto possiamo imparare da lui a non credere a verità stereotipate, ma a cercare di scoprire qual è il significato più profondo della realtà. Ma allo stesso tempo non si tratta della curiosità rappresentata, ad esempio, dai teorici della cospirazione di Internet, le cui pseudo-teorie sono incoerenti e basate su conoscenze frammentarie. Socrate avrebbe sicuramente scoperto tali incongruenze. E li ha smascherati senza pietà.
PAP: Nel suo libro lei mostra Socrate sullo sfondo della sua epoca e in relazione a vari fenomeni ed eventi politici del suo tempo. Come hanno influenzato l'attività filosofica di Socrate?
K.Ł.: Credo che la filosofia antica debba essere discussa nel suo intero contesto culturale, storico, religioso, sociale e letterario, perché era costantemente in dialogo con il suo ambiente. L'epoca di Socrate era molto turbolenta. La prima parte della sua vita cade nella gloriosa epoca di Pericle. Fu un periodo in cui ad Atene la democrazia stava prendendo forma e l'arte e la letteratura si stavano sviluppando dinamicamente. Sebbene Atene stesse già allora mostrando tendenze imperiali e sottomettendo altri stati greci. Successivamente, nel 431 a.C., scoppiò la devastante guerra del Peloponneso tra Atene, Sparta e i loro alleati. Dura un quarto di secolo e si conclude con la sconfitta di Atene.
Lo storico greco Tucidide scrisse a quel tempo che i confini attraversavano il centro degli stati perché gli stati greci erano polarizzati e devastati da conflitti interni. Una parte è rappresentata dai democratici, sostenuti da Atene, l'altra dagli oligarchi, sostenuti da Sparta. In questo modo, Atene e Sparta, in quanto attori più importanti, cercano di manipolare i loro alleati più piccoli, mettendo le due fazioni l'una contro l'altra. Ciò a sua volta portò a guerre civili.
Socrate individua diverse patologie nella vita sociale che si manifestavano nell'Atene di quel tempo, come il populismo e la polarizzazione, fenomeni vicini anche ai nostri tempi. Non rimane indifferente a questi fenomeni, ma cerca di convincere gli Ateniesi ad essere ragionevoli, moderati e a riflettere sul proprio comportamento.
PAP: Qual è il significato della sua disputa con i sofisti?
K.Ł.: Quando i sofisti compaiono ad Atene, insegnano, tra le altre cose, la retorica, l'arte di parlare in modo efficace, che è uno strumento utile in politica. Si è poi capito che tale persuasione degli ascoltatori non ha necessariamente a che fare con il dire la verità, ma può basarsi sulla manipolazione di argomenti e parole. Come dimostra Tucidide, la manipolazione del linguaggio diventa anche un'arma nella guerra contemporanea, alimentando atti di aggressione.
Socrate, in opposizione ai sofisti, cerca di definire i concetti etici, chiedendosi cosa sia la giustizia, cosa sia la bontà. Da una parte abbiamo l'offuscamento populista dei significati e dei concetti, dall'altra Socrate, che cerca di chiarire il significato dei termini affinché non possano essere manipolati. Lo sappiamo molto bene perché nel XX secolo i regimi totalitari facevano ricorso alla propaganda. Ne parlo nel libro, citando l'esempio di Victor Klemperer, un filologo ebreo che monitorò e analizzò costantemente il linguaggio emergente della propaganda nel Terzo Reich.
Quando proiettiamo la figura di Socrate nel contesto politico del suo tempo, possiamo comprendere meglio cosa stesse facendo ad Atene. Qual è il senso delle sue continue domande sul significato dei concetti etici? Si tratta di un tentativo di difendersi dal populismo, che offusca il significato delle parole. Ecco perché mi sembra che Socrate possa essere per noi un punto di riferimento importante, qualcuno che ha affrontato problemi simili a quelli che affrontiamo noi oggi. In questo contesto è una figura estremamente moderna.
PAP: Il metodo socratico di porre domande ha trovato oggi altre applicazioni pratiche?
K.Ł.: Viene utilizzato, ad esempio, in psicologia. Sono stati ideati vari tipi di terapie che utilizzano il dialogo socratico. Viene utilizzato anche come metodo per interrogare imputati e testimoni. Uno dei miei film preferiti è "La parola ai giurati" di Sidney Lumet. Credo che questo sia un ottimo esempio di come utilizzare il dialogo socratico in difesa di una persona accusata ingiustamente. A loro volta, nell'educazione saggia, gli studenti sono incoraggiati a pensare incoraggiandoli a porre domande. È importante che siano loro stessi a trovare una soluzione al problema. Perché le domande socratiche riguardano la scoperta della verità dentro di sé. E questa formulazione indipendente della verità ha un valore maggiore, una carica emotiva maggiore, rispetto a quando qualcuno ci fornisce una soluzione già pronta.
PAP: Oltre alla prospettiva politica e storica, lei parla di Socrate in un contesto un po' più privato. Particolarmente interessante sembra essere la storia di Santippe, la moglie del filosofo, finora non solo emarginata nella letteratura, ma anche presentata come un personaggio estremamente litigioso.
K.Ł.: In effetti, la tradizione di mostrare Santippe è molto ingiusta nei suoi confronti. È stata etichettata come una bisbetica, una mascalzona, una donna che impedisce solo al suo grande marito di cambiare il mondo. Innanzitutto questa visione è sicuramente esagerata. In secondo luogo, anche se Santippe aveva delle lamentele nei suoi confronti per varie cose, molto probabilmente lo aveva fatto per una buona ragione. Suo marito non prestava attenzione alle cose banali, eppure avevano dei figli di cui prendersi cura. Nella letteratura polacca, ad esempio, Ludwik Hieronim Morstin si occupò della causa della moglie di Socrate nel suo dramma "La difesa di Santippe".
Attraverso questo personaggio ho voluto mostrare la condizione della donna a quei tempi. Spesso idealizziamo Atene come un periodo magnifico, il che è in parte vero. La vita politica, tuttavia, era limitata ai cittadini e solo gli uomini potevano essere cittadini. Le donne erano condannate a rimanere nella sfera privata e non avevano praticamente alcuna indipendenza giuridica. Hannah Arendt una volta disse che gli uomini vivevano nella luminosa e soleggiata agorà, mentre le donne erano condannate all'oscuro oikos, la sfera domestica, una vita dedicata allo svolgimento di onerosi lavori domestici.
PAP: E com'era Socrate, a parte il fatto che non era un marito ideale?
K.Ł.: In varie fonti troviamo molti dettagli interessanti sul carattere di Socrate, sul suo aspetto e sul suo stile di vita. Platone scrive che era estremamente forte fisicamente, resistente al freddo e coraggioso sul campo di battaglia. Durante una campagna militare camminò a piedi nudi sul ghiaccio e riuscì a sopportare la fame. Ma quando il vino era abbondante, nessuno riusciva a bere quanto lui, e nessuno lo vedeva ubriaco. Cadde in strani e misteriosi stati meditativi. Platone racconta di come una volta rimase fermo per un giorno intero e rifletté su una certa questione. Rimase così per tutto il giorno, poi per tutta la notte e, quando spuntò il sole, i suoi dubbi dovettero essere risolti, perché tornò a comportarsi normalmente. Queste sono qualità molto interessanti di Socrate. Creano un personaggio che deve essere stato straordinario, carismatico e che ha lasciato un'enorme impressione sui suoi contemporanei.
***
Dott. Habil. Krzysztof Łapiński ha tradotto, tra gli altri: le "Meditazioni" di Marco Aurelio e le "Lezioni stoiche" di Musonio Rufo, ed è autore di una monografia su Marco Aurelio. Scrive anche libri per bambini. Łapiński è borsista della Fondazione Kościuszko e della Fondazione Lanckoroński di Brzezie e direttore del Centro di ricerca comparata sulla filosofia dell'Oriente e dell'Occidente presso l'Università di Varsavia.
Ewelina Krajczyńska-Wujec (PAP)
ekr/ bar/ amac/
naukawpolsce.pl





